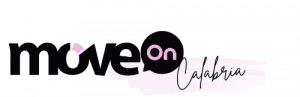Per Soverato e Catanzaro, la notte tra il 9 e il 10 settembre del 2000 non è mai davvero finita. È rimasta lì, sospesa tra il boato del torrente Beltrame e il silenzio assordante del giorno dopo, quello in cui si cominciò a contare i morti e le promesse mancate. Venticinque anni dopo, il tempo ha curato molte cose, ma non quella ferita; perché ci sono dolori che non si chiudono: insegnano e inchiodano.
A un quarto di secolo da quell’alluvione che cancellò in pochi minuti il campeggio “Le Giare”, dove si trovavano i volontari e i partecipanti al campo scuola dell’Unitalsi di Catanzaro, Soverato si è fermata di nuovo. Non solo per ricordare le 13 vittime, travolte da un’onda di fango e di responsabilità, ma per ribadire che il ricordo non può essere solo una liturgia, deve diventare direzione.
Sulle rive del Beltrame, dove la memoria è più densa dell’acqua che scorre, si sono ritrovati cittadini, autorità civili, religiose e militari. Una celebrazione solenne, presieduta dall’arcivescovo metropolita Claudio Maniago, ha raccolto sotto lo stesso cielo chi non ha mai dimenticato e chi ha imparato a farlo. Volti segnati, occhi lucidi. E domande che, nonostante le condanne arrivate in Cassazione per omicidio colposo, restano sospese come nuvole mai scaricate del tutto.
I sindaci Daniele Vacca (Soverato) e Nicola Fiorita (Catanzaro) non hanno avuto timore di riaprire la ferita. Hanno scelto di farla bruciare, per non renderla sterile.
«Da quella tragedia è nato un dovere: costruire una cultura della prevenzione, imparare a non voltarsi mai dall’altra parte», hanno detto dal palco, davanti a una comunità che, ancora oggi, si aggrappa a quei nomi scolpiti nella pietra come fossero radici.
Perché Le Giare non era solo un campeggio. Era un luogo di cura, di solidarietà, di umanità vera. E fu proprio l’umanità a mostrarsi nella sua forma più alta quella notte: nei volontari che non fuggirono, che provarono a salvare i più fragili, anche a costo della vita. Mentre lo Stato, ancora una volta, restava indietro: freddo, distante, impreparato.
Nel volto delle istituzioni presenti oggi, sedute in prima fila, si è riflesso anche quel passato: fatto di dolore, ma anche di resistenza. Di chi ha scelto di restare e di ricordare, non con nostalgia ma con responsabilità.
Perché la prossima piena arriverà. E allora dovrà trovare un territorio meno fragile. E una coscienza più giusta.